Pionieri dimenticati: Ann Davison fu la prima donna ad attraversare l'Atlantico a vela in solitario
YACHT-Redaktion
· 31.10.2025





Ann Davison era un pilota, aveva pilotato piccoli aerei e viveva su una piccola isola in un lago. Poi, insieme al marito Frank, acquistò una vecchia barca con la quale volevano fare il giro del mondo. Dopo due anni di duro lavoro, ma ben lungi dall'essere completamente restaurata, nel maggio 1949 lasciarono la loro casa in Inghilterra per sfuggire ai creditori.
Interessante anche questo:
Seguirono due settimane da incubo, fatte di giorni e notti insonni, guasti al motore, venti sfavorevoli e navigazione difettosa. L'imbarcazione si arenò sulle rocce di Portland Bill, un promontorio nel Canale della Manica con correnti insidiose. Ann e suo marito dovettero abbandonarla nel cuore della notte e cercare di scendere a terra. Tuttavia, la marea li spinse al largo e dovettero gridare l'uno all'altro per comunicare nel mare impetuoso. La loro zattera di salvataggio - un gommone aperto con uno scafo di tela tenuto insieme da corde - si è ribaltata più volte.
I due sopravvissero alla notte e al mattino successivo. Poi le onde aumentarono di altezza e li portarono ancora più al largo. Il freddo e un'onda particolarmente forte colpirono Frank così duramente che annegò. Ann andò alla deriva, stordita, finché alla fine la marea che si rovesciava e un cambiamento del vento le diedero l'opportunità di portare la zattera di salvataggio abbastanza vicino alla riva con una pagaia per nuotare fino alla salvezza. È riuscita ad arrampicarsi sugli scogli, dove ha trovato aiuto. Nonostante l'orrore e la stanchezza, in quel momento ha capito che doveva tornare in mare. Il suo rapporto con il mare aperto, scrive, non poteva e non doveva finire così.
Dare alla vita un nuovo significato
Qualche anno dopo, Davison acquistò una barca a vela in legno che - coincidenza o destino? - fu chiamata "Felicity Ann". Voleva diventare la prima donna a tentare di navigare da sola attraverso uno dei grandi oceani. Frank aveva fatto esperienza come navigatore in solitario nel Golfo di San Lorenzo, ma questo prima che Ann lo conoscesse. Ann non stava cercando di superarlo con il suo piano, né di dimostrare qualcosa o di fare qualche dichiarazione. Non voleva altro che dare un nuovo significato alla sua vita.
Info: Ann Davison
La britannica fu la prima donna ad attraversare l'Atlantico nel 1952/53. Quando partì da Plymouth non aveva quasi nessuna esperienza di navigazione. La sua "Felicity Ann" era lunga solo sette metri e costruita in legno. In seguito Davison scrisse un libro sulla sua avventura, che fu pubblicato in tedesco con il titolo "... und mein Schiff ist so klein". Ulteriori informazioni sulla barca: nwswb.edu/felicityann
Dopotutto, doveva avere un certo carisma, perché ricevette un grande aiuto entusiasta nel suo tentativo di acquistare ed equipaggiare la "Felicity Ann". Portò avanti il suo progetto con determinazione per diversi mesi, fino a quando lasciò il porto di Plymouth il 18 maggio 1952, all'età di 38 anni, tre anni e un giorno dopo essere salpata con Frank.
Nel trambusto della discesa, ha rischiato di scontrarsi con una delle barche di scorta, ma alla fine il convoglio di giornalisti e amici è rimasto indietro. Il sole stava tramontando. Ann cercò di rilassarsi e tenne d'occhio le altre barche. Seduta nel pozzetto, cercò una posizione comoda per governare.
Per la seconda volta, si diresse verso ovest e si ritrovò nelle stesse acque in cui era andata alla deriva con la zattera di salvataggio, ma questa volta da sola, con la sua barca e con la ferma intenzione di navigare direttamente verso l'isola di Madeira, a circa 1.200 miglia nautiche di distanza.
Attrezzatura della barca rudimentale per l'epoca
Davison era dolorosamente consapevole di non sapere quasi nulla del motore che era a bordo e ancor meno della navigazione. Le era stata fatta una breve introduzione alla navigazione astronomica, che a suo dire l'aveva lasciata piuttosto confusa, ma poiché era incline all'autoironia, non bisognava crederle sulla parola.
Grazie alla sua esperienza di pilota di piccoli aerei, aveva familiarità con la lettura delle mappe (comprese le carte nautiche per la navigazione), con l'orientamento della bussola e con il calcolo dei tempi morti. Aveva una radio a bordo, per cui poteva ascoltare la BBC e regolare l'orologio di bordo utilizzando i segnali orari. Tuttavia, non poteva mettersi in contatto con gli altri, nemmeno con le navi vicine. Le radio con trasmissione bidirezionale, le apparecchiature radar in grado di riconoscere le navi e la rotta della costa e gli ecoscandagli per misurare la profondità erano ancora agli albori ed erano a disposizione di pochissimi marinai.
Soprattutto, però, Davison non aveva a bordo né un dispositivo elettrico né uno meccanico con cui la "Felicity Ann" avrebbe potuto governarsi. Era seduta alla barra ora dopo ora, giorno dopo giorno. Se le condizioni lo permettevano, poteva sistemare la barra o combinarla con la posizione delle vele e lasciare la barca a se stessa per un breve periodo. Il più delle volte, però, per poter mangiare o dormire in pace, doveva girare le vele in modo che la barca fosse stabile in acqua senza andare avanti. Oppure issava le vele. In ogni caso, durante questo periodo non si avvicinava alla sua destinazione, a meno che non si allontanasse da essa.
Le crociere costiere consentono a Davison di fare esperienza
Essendo una barca di legno, la "Felicity Ann" imbarcava sempre un po' d'acqua, almeno all'inizio del viaggio, anche se le assi erano già gonfie. Ora il legno si è adattato ai movimenti in mare aperto. Il quinto giorno di viaggio, le pompe di sentina erano intasate perché avevano raccolto segatura e altri residui del lavoro in cantiere. Ann si sentì incapace di rimettere in funzione le pompe. Era "troppo spenta dalla fatica", come disse lei stessa. Poiché la sua barca era immersa nell'acqua, si fece trainare da pescatori francesi fino al porto di Douarnenez, sulla costa atlantica della Bretagna. Poi continuò il suo viaggio in modo non pianificato: viaggiò lungo la costa, prima fino a Vigo, poi a Gibilterra e infine a Casablanca.
Ha iniziato la sua traversata atlantica all'apice dell'interesse pubblico per l'oceano.
Questa tattica si rivelò azzeccata, in quanto permise a Davison di fare esperienza lungo il percorso, di scoprire quali provviste le servivano e quali no, e di commettere errori che non avrebbe dovuto commettere in mare aperto.
Al largo delle coste della Spagna e del Portogallo, la "Felicity Ann" e il suo skipper dovettero tenersi lontani dalle grandi rotte marittime che conducevano ai numerosi porti e fare attenzione alla corrente portoghese. Nella fitta nebbia al largo di Finisterre, Davison fu costretto a colpire una padella perché aveva dimenticato di portare con sé una sirena da nebbia. Sulla rotta per Gibilterra, fu quasi speronata da un mercantile nel cuore della notte.
"Il mare era selvaggio", scrive parlando di sé e della sua barca, "e noi eravamo sdraiati senza un briciolo di vela, quando all'improvviso apparve un piroscafo sulla cresta di un'onda. Un triangolo di luci, quella rossa di babordo, quella verde di tribordo e quella bianca del piroscafo, veniva dritto verso di noi".
Davison non ebbe il tempo di salpare e di darsi alla fuga. Così scese sottocoperta per avviare il motore. I motori marini da incasso per piccole imbarcazioni esistevano già da decenni, ma il diesel da cinque cavalli doveva ancora essere avviato a mano. Davison si inginocchiò davanti al motore e, "alimentata dalla mia paura", girò la manovella finché il motore non prese vita. Poi tornò in cabina di pilotaggio e inserì la marcia. L'elica cominciò a girare. All'ultimo momento riuscì a evitare il cargo. Probabilmente non l'aveva nemmeno notata. "Da quel momento non ho più dormito", racconta Davison.
L'avventura di Davison cattura lo spirito del tempo
Il resoconto di Ann Davison della sua traversata atlantica si intitola "... e la mia nave è così piccola" ed è, a mio parere, uno dei libri più abili, meticolosi, divertenti e poetici mai scritti da un marinaio di una sola mano al suo ritorno.
Quando Davison partì per il suo viaggio, Thor Heyerdahl e i suoi compagni avevano appena completato con successo il viaggio dal Perù alla Polinesia francese. La spedizione su zattera, il libro "Kon-Tiki" del 1951, diventato un bestseller, e l'omonimo film-documentario premiato con l'Oscar scatenarono un'ondata di entusiasmo in Europa e in Nord America per tutto ciò che aveva a che fare con l'oceano e la fuga dal mondo che prometteva.
Insieme al collega Émile Gagnan, il francese Jacques Cousteau inventò l'erogatore e realizzò i primi filmati subacquei.
Nel 1951, l'ittiologa americana Eugenie Clark fu la prima biologa marina a pubblicare le sue memorie con il titolo "Lady with a Spear", che ottenne subito un grande successo.
Rachel Carson ha avuto due libri nella classifica dei bestseller del New York Times. "Sotto il vento del mare" del 1941 e "I segreti del mare" del 1951 raccontano una storia naturale del mare avvincente e scientificamente fondata.
In un articolo pubblicato sulla rivista "Life", Davison descrive la sua traversata atlantica per la prima volta nel 1953. L'articolo è incorniciato da raccapriccianti foto in bianco e nero della guerra di Corea - soldati che marciano con noncuranza davanti a cadaveri e puntano i fucili contro i soldati "nemici" della Corea del Nord - e da una pubblicità a colori del film hollywoodiano del 1953 "Ritorno al paradiso": sullo sfondo dell'oceano turchese si vedono donne poco vestite e marinai che si sbaciucchiano, che Gary Cooper portò sull'isola dei mari del Sud.
Disposizioni per 60 giorni
Quasi all'apice dell'interesse pubblico per l'oceano, il 20 novembre 1952 Ann Davison lasciò Gran Canaria a bordo della "Felicity Ann" e partì per l'Atlantico. Pochi giorni dopo, il mondo venne a sapere che gli Stati Uniti avevano fatto esplodere la prima bomba all'idrogeno nelle Isole Marshall poche settimane prima. Il fungo atomico raggiunse un'altezza di quindici chilometri.
Davison stava per intraprendere un viaggio di 2.600 miglia nautiche. Il viaggio era iniziato con nuvole scure e pioggia, ma con un vento promettente. Sapeva che poche settimane prima di lei, un medico francese di nome Alain Bombard era partito con un gommone lungo solo 4,6 metri e con una sola vela.
Bombard aveva un sestante, una rete da pesca a maglie strette e due macchine fotografiche che la rivista "Life" gli aveva regalato. A parte alcune razioni di emergenza, non c'erano provviste a bordo, ma questo faceva parte del suo piano, poiché voleva dimostrare che l'oceano aveva acqua potabile e cibo a sufficienza per sfamare una persona "dal solo valore nutrizionale del plancton", come disse "Life". La destinazione di Bombard furono le Barbados, dove arrivò dopo poco più di due mesi. L'anno successivo pubblicò il libro "Im Schlauchboot über den Atlantik".
Davison aveva a bordo della "Felicity Ann" acqua potabile e cibo come uova, frutta, patate, farina di mais e fette biscottate per sessanta giorni, una quantità che lei stessa considerava eccessivamente prudente, dato che stimava che l'intero viaggio avrebbe richiesto dai trenta ai quaranta giorni. I venti alisei costanti di solito rendono il viaggio verso ovest, verso i Caraibi, relativamente rilassato.
Passat apparentemente mancata
Alle Isole Canarie, un amico le aveva regalato un barattolo di budino alle prugne con la scritta: "Probabilmente sarai a destinazione per Natale, ma non si è mai troppo sicuri". Ma sebbene la partenza fosse stata ritardata, Davison pensava che avrebbe trascorso il Natale a bere qualcosa a English Harbour, ad Antigua, o in un posto vicino. Non aveva nemmeno messo in valigia un almanacco nautico per l'anno successivo, essenziale per la navigazione astronomica.
Davison aveva a bordo cibo per sessanta giorni, cosa che lei stessa considerava eccessivamente prudente.
Il giorno di Natale, Ann Davison, prossima alla pazzia, si trovava a galleggiare in un tratto di mare dove, per quanto ne sapeva, avrebbero dovuto soffiare gli alisei. Evidentemente le era sfuggito. Solo in alcuni giorni del suo viaggio il vento era stato dalla sua parte. Solo raramente aveva visto i cumuli gonfiati che i marinai che si dirigevano dall'Europa ai Caraibi seguivano da secoli, e solo per poche ore al massimo, cosicché il 25 dicembre aveva coperto al massimo la metà della distanza. Non poteva esserne del tutto sicura perché non si fidava molto delle sue capacità di navigazione.
Le mancava l'esperienza. Poi c'era la paura delle tempeste. E nessun bollettino meteorologico la raggiungeva.
La cabina della sua barca era come una sauna, la superficie del mare come piombo. Nei giorni in cui il mare era calmo, faceva girare il motore per due ore solo per uscire dall'acqua e sentire il vento in faccia. Si rese conto con trepidazione che lo scafo della "Felicity Ann" era ricoperto di pesanti incrostazioni, che rallentavano ulteriormente la barca.
Quando il vento soffiava, di solito era da ovest. Le piccole imbarcazioni con armo tradizionale come la "Felicity Ann" navigano meglio quando il vento soffia da cinquanta o sessanta gradi. Quindi, per navigare verso ovest con un vento da ovest, doveva dirigersi verso nord-nord-ovest, poi virare e proseguire verso sud-sud-ovest. In mare aperto, dove non arrivavano previsioni meteorologiche a medio termine, non era facile decidere quando virare. Non aveva modo di sapere quando il vento sarebbe cambiato, dove l'avrebbero portata le correnti e quale prua l'avrebbe portata più velocemente a destinazione. Inoltre, le mancava l'esperienza.
Poi c'era la paura delle tempeste. La stagione degli uragani non era ancora iniziata, ma il tempo atipico faceva temere l'arrivo di una tempesta. Di tanto in tanto, si abbattevano forti raffiche che sembravano uscite dal nulla. Non c'era nessuno con cui potersi consultare. Persino la ricezione della radio era disturbata. Non potendo ascoltare la BBC, consultò tutti i libri che aveva a bordo sulle condizioni meteorologiche dell'Atlantico. Tuttavia, in seguito non fu molto più intelligente.
Pressione psicologica ed emotiva
Chiunque non abbia vissuto una situazione simile può difficilmente immaginare quanto siano grandi la pressione emotiva e i dubbi. Questi ultimi sono ulteriormente alimentati dalla mancanza di sonno che ha avvolto Davison come un velo mentre passava giorno dopo giorno sulla sua barca, lunga solo sette metri, a guardare l'infinita distesa dell'oceano.
Davison decise di aprire il barattolo di budino alle prugne. Quando morse il dolce, ebbe difficoltà a inghiottire la frutta secca che conteneva. Senza ulteriori indugi, prese il barattolo e lo gettò in mare con un arco elevato, dove rimase a galla per diverse ore prima di riprendere i sensi e affondare.
Quando ci si muove lentamente come Davison o il dottor Bombard, a volte si trova conforto nel fatto di avere un'enorme quantità di tempo per contemplare l'ambiente in cui ci si trova, in questo caso le latitudini temperate dell'Atlantico. Ma anche se un giorno un arcobaleno le rallegrò l'umore, Davison non era una di quelle che si sarebbero fatte contagiare dall'ambientalismo emerso nei primi anni Cinquanta. Il suo viaggio si svolse sotto altri auspici.
Dopo 65 giorni di navigazione, la nave gettò l'ancora in un piccolo porto di Dominica.
In nessun punto del libro si parla dell'oceano in quanto tale, dell'acqua salata e del richiamo che tanti Ismaele hanno seguito, radunandosi nei porti o imbarcandosi da soli su una nave.
Quasi nessuna affinità con l'oceano
Ci si potrebbe chiedere perché Davison non abbia intrapreso un'escursione attraverso le Alpi o le Montagne Rocciose. Non abbiamo mai sentito dire che l'oceano è sconfinato e libero, che ha poteri curativi o che dobbiamo proteggerlo. Né ha annotato quali animali ha visto in che numero o quali comportamenti ha osservato.
L'oceano di Davison era come un purgatorio in cui regnava la calma. Le aveva portato via il marito. Quando fumava una sigaretta, gettava il mozzicone in mare con noncuranza. Faceva lo stesso con la spazzatura che si accumulava ogni giorno. Quando alcune lattine galleggiavano verso di lei in mezzo al mare, non reagiva con disgusto o indignazione. Li prendeva come un segno confortante del fatto che non era sola nel grande mondo e come una garanzia che c'erano altre persone intorno a lei.
All'epoca le istruzioni pratiche per i marinai venivano pubblicate ancora con molta esitazione, ma Davison non avrebbe comunque preso a bordo tali libri, se la sua impressione non fosse stata ingannevole. A parte un libro sui pesci, preferiva titoli che trattavano di navigazione. C'erano anche volumi di poesia.
Non era una di quelle che considerava amici i delfini cigolanti che accompagnavano la barca. Anche quando si sedette a scrivere il suo libro dopo il viaggio, non rivelò alcun legame spirituale con i mammiferi marini o con qualsiasi altra forma di vita d'alto mare.
Il mare come natura selvaggia in cui bisogna affermarsi
Se Davison aveva un'affinità, era per i banchi di pesci che seguivano la Felicity Ann, soprattutto quelli piccoli che si cibavano della vegetazione dello scafo. Non tentava di pescare - il pensiero di uccidere un pesce la metteva a disagio - ma non disdegnava i pesci volanti che atterravano sul ponte e vi morivano. La prima volta che lo fece, si sentì obbligata a farlo perché ne aveva letto spesso. Il pesce fu fritto nel burro e le piacque molto.
Davison menziona i pesci e le altre creature marine solo molto raramente e come se fossero nuvole dalla forma strana o, per scegliere un esempio terrestre, una pianta del giardino di casa che cattura la sua attenzione in una terra straniera. In sostanza, questi passaggi non sono altro che una spezia che la scrittrice aggiunge al suo libro senza collegarli a un messaggio morale o a una dichiarazione sullo stato dell'oceano.
Un incidente avvenuto a metà gennaio fornisce informazioni più eloquenti sul suo rapporto con il mare. Mentre il suo viaggio verso ovest si trascinava per un tempo estenuante, tre grandi squali si unirono alla "Felicity Ann". Due la accompagnarono lateralmente e uno la seguì nella sua scia. Davison trovò gli animali "indescrivibilmente sinistri", avvicinandosi così tanto alla barca che le bastò allungare la mano per toccarli.
Davison credeva che l'uomo non potesse apprezzare il mare più del cielo o dello spazio. Per lei il mare era una natura selvaggia in cui bisognava affermarsi, quindi era più nella tradizione di Joseph Conrad che nella scia di Rachel Carson e Jacques Cousteau. Per Davison, l'amore per il mare era l'amore per la navigazione e "l'illusione di dominare l'oceano".
Arrivo dopo 65 giorni
Dopo un'estenuante navigazione di sessantacinque giorni, che le aveva provocato, tra l'altro, un doloroso orzaiolo e diversi ascessi, Ann Davison gettò l'ancora in un piccolo porto di Dominica il pomeriggio del 24 gennaio 1953. Era così diventata la prima donna ad attraversare un oceano da sola.
Le ultime parole del libro riguardano il coraggio, che l'autrice descrive come una miscela di resilienza, determinazione e capacità di imparare dagli errori.
Ho comprato la mia copia del libro in una libreria antiquaria. Nell'ultima pagina, il precedente proprietario ha fatto alcune note a matita, le ultime parole del libro sono sottolineate con linee rette: "Ma ho dovuto navigare per migliaia di miglia attraverso l'oceano per scoprire che il coraggio è la chiave della vita".
Il libro: "Soli in mare
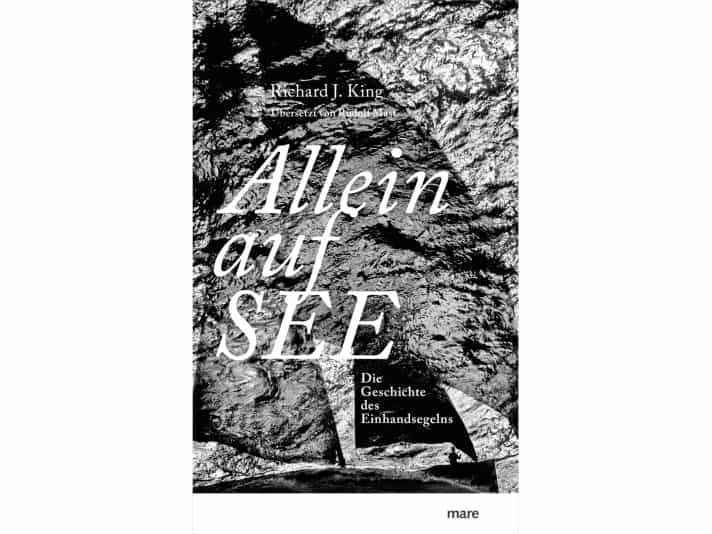
L'autore Richard J. King ripercorre la storia della navigazione in solitario in questo libro, ora pubblicato in tedesco. Approfondisce anche la questione delle motivazioni che hanno spinto i protagonisti e descrive numerose imprese pionieristiche a lungo dimenticate. mare, 28 euro

